Storia del sabir: la lingua franca dei marinai
Per oltre 400 anni nelle navi e nei porti del Mediterraneo si parlava uno straordinario idioma nato da una mescolanza di genovese, veneziano, turco, catalano e occitano
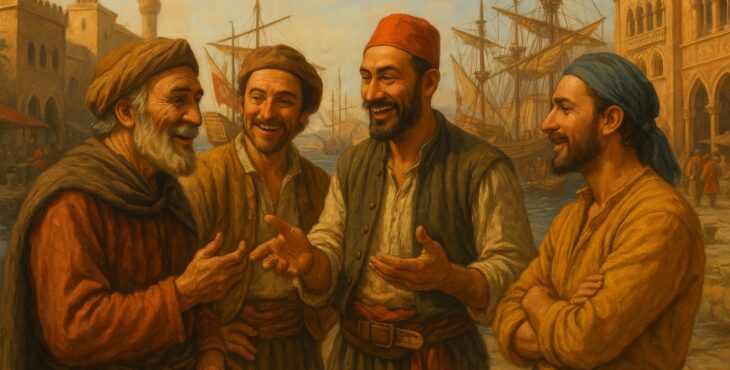
Storia del sabir: la lingua franca dei marinai
Per oltre 400 anni nelle navi e nei porti del Mediterraneo si parlava uno straordinario idioma nato da una mescolanza di genovese, veneziano, turco, catalano e occitano
“Se ti sabir ti respondir, se non sabir tazir, tazir”. Così, nell’opera teatrale Il Borghese Gentiluomo di Molière, il finto giureconsulto turco apostrofa il ricco ed ingenuo Monsieur Jourdain, ansioso di ottenere un titolo nobiliare per la sua casata. “Se sai il sabir rispondi, altrimenti taci e taci”: il grande commediografo francese usa la lingua sabir per canzonare il protagonista della sua opera teatrale. Non era una novità, per il teatro comico, l’uso scherzoso di questo idioma. Anche Carlo Goldoni nelle sue opere “L’impresario delle Smirne” e “La famiglia dell’antiquario” fa parlare in sabir alcuni suoi personaggi per sottolineare la loro provenienza marinara.
La lingua del mare
Il sabir infatti è una lingua che viene dal mare. Una lingua che, pur con varianti locali, era parlata da tutti i marinai e in tutti i porti del Mediterraneo. E non soltanto. Il sabir era anche la lingua degli schiavi e dei galeotti ai remi. Era la lingua dei pirati, dei diplomatici e dei viaggiatori che si recavano oltremare. Una lingua indispensabile per i commerci e la navigazione. Basti pensare che il primo portolano completo del Mediterraneo, il “Compasso da Navegare”, pubblicato nel 1296, era scritto proprio in questo idioma.
Nascita e morte del sabir
Il sabir si diffuse in tutto il bacino Mediterraneo attorno al XVI secolo, grazie all’uso che ne fecero le Repubbliche corsare di Tunisi, Algeri e Tripoli che avevano necessità di comunicare con i mercanti delle Repubbliche marinare e degli altri porti europei. Era una lingua semplice, nata da e per i marinai, con un uso limitatissimo di tempi verbali, una morfologia agevole e un ordine delle parole libero. Il lessico pescava per lo più da dialetti italiani come il genovese, il veneziano e, in misura minore, il siciliano, mescolandoli a lingue come il catalano, il greco, l’occitano e naturalmente il turco. Ancora oggi chi parla il veneziano non ha nessuna difficoltà a comprendere il sabir.
Il sabir declinò velocemente dopo il 1830, con la conquista francese dell’Algeria e l’espandersi di questa potenza coloniale che impose come lingua franca, quella francese. Lingua tutt’oggi in uso sull’altra sponda del Mediterraneo non senza particolari varianti locali che molti linguisti considerano vere e proprie continuazioni del sabir che, in questo modo, più che scomparire, si è francesizzato. Ma per almeno 400 anni il sabir fu la lingua più parlata nel Mediterraneo e rimane tuttora l’idioma pidgin, cioè una lingua semplificata nata dalla mescolanza di più culture, più longevo di cui abbiamo conoscenza.
Argomenti: mediterraneo




